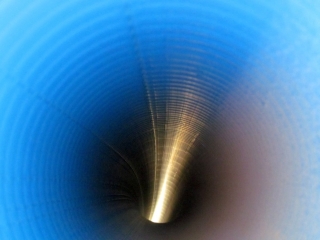Tagliare le pensioni d’oro? Un’ingiustizia?
No, un’imbecillità economica!
Come le maree che si susseguono ciclicamente, si torna a parlare di tagli alle pensioni. Questa volta in rapporto alla proposta di finanziamento del cosiddetto “reddito di cittadinanza” avanzata dai Cinque Stelle. Interviene sul Fatto Economico del 20 dicembre il Prof. Arrigo (Taglio alle pensioni d’oro: ecco perché non si può parlare di un’ingiustizia) per sostenere che, anche se si procedesse a tagli a partire da un ammontare di 3.000 euro lordi mensili, non ci sarebbe alcuna ingiustizia.
Notoriamente il giusto e l’ingiusto sono determinazioni storiche, che mutano più o meno profondamente nel tempo, anche se la maggior parte di coloro che brandiscono queste categorie nel confronto non sono quasi mai consapevoli della natura contingente dei valori che professano. Per loro il giusto non è dell’uomo, con tutti i limiti storici che ne caratterizzano la cultura acquisita, ma un criterio che lo sovrasta. L’argomentazione con la quale il Prof. Arrigo giustifica il suo giudizio non fa eccezione perché, come tutti i paladini del giusto, descrive le pratiche sociali diverse da quelle che riesce a concepire, e che considera immanenti, come arbitrarie. Vale a dire che non sembra essere nemmeno lontanamente consapevole del fatto che esse hanno solide radici in un pensiero economico del quale dà l’impressione di ignorare l’esistenza. Un sistema di pensiero che, vista la grave crisi di quello oggi prevalente, potrebbe ben presto tornare a rinverdire.
L’argomento del Prof. Arrigo è semplice, e va a nozze con l’ingenuo senso comune, che però non pretende di “fare scienza”. Le pensioni non sarebbero altro che quell’istituto attraverso il quale ognuno di noi riceverebbe indietro, nella forma di un vitalizio, quei soldi che ha versato come contributi durante il periodo lavorativo. Non sarebbe, dunque, giusto che qualcuno riceva complessivamente una somma maggiore di quella che dovrebbe essere considerata come il suo tesoretto, accantonato nel corso della vita lavorativa. Poiché chi gode di una pensione lorda di 3.000 ha mediamente versato una somma complessiva inferiore di circa il 30% a quanto sta ricevendo, sarebbe giusto togliergli questo di più. Ecco la fonte del reddito di cittadinanza, dalla quale potrebbero scaturire ben 17,4 miliardi di euro, invece dei soli 12 prospettati dai Cinque Stelle!
Ma il problema è che il sistema pensionistico prevalente prima delle numerose controriforme degli ultimi decenni è stato concepito proprio garantendo intenzionalmente dei rendimenti pensionistici superiori rispetto ai contributi. Questi non erano affatto considerati come un tesoretto individuale, ma ciò che effettivamente erano nell’ambito del metodo a ripartizione, cioè il corrispettivo del mantenimento dei lavoratori in pensione che ogni generazione mette a disposizione di quella che l’ha preceduta. Per questo troviamo che tutti i trattamenti pensionistici in auge superano significativamente i contributi versati. Così, quelli fino a 1.000 euro eccedono i versamenti di circa il 16%, quelli tra 1.000 e 2.000 euro eccedono di circa il 25% e quelli tra 2.000 e 3.000 euro eccedono di circa il 29%. Ora, se il giusto corrisponde al “riconoscere e a dare a ciascuno ciò che gli è dovuto”, sarebbe cosa davvero strana il giungere alla conclusione che a macchiarsi dell’ingiustizia fosse l’intera popolazione dei pensionati. (Anche se i teorici del cosiddetto conflitto tra generazioni sostengono proprio questa tesi bislacca.) Non bisognerebbe piuttosto riconoscere che quel comportamento corrispondeva ad una pratica della quale, chi ragiona come Arrigo, non capisce il fondamento e alla cultura oggi prevalente appare ingiustificata solo perché la sua validità teorica è stata rimossa?
La storia dell’umanità è costellata di passaggi del genere, coi quali le pratiche dei predecessori vengono degradate a comportamenti arbitrari, nonostante quando esse furono elaborate apparissero e fossero del tutto sensate. Ma non sempre i successori avevano realmente ragione nell’avanzare questo giudizio. Basti vedere la questione della regolamentazione del credito bancario introdotta negli anni trenta e prontamente liquidata col neoliberismo, che si è dovuta reintrodurre recentemente (e confusamente), quando la crisi ha raggiunto il suo apice.
Il quesito col quale il Prof. Arrigo ci impone di confrontarci è dunque il seguente: i pensionati debbono ricevere indietro solo l’equivalente del “tesoretto” corrispondente ai contributi versati o possono pretendere per diritto – il diritto riconosciuto sul finire degli anni sessanta – un trattamento superiore a quell’ammontare? Insomma starebbero perpetrando un arbitrio economico, al quale occorrerebbe porre rimedio, o debbono piuttosto organizzarsi per non subire loro un arbitrio corrispondente ad un’ulteriore decurtazione delle pensioni riconosciute dalla società?
Per rispondere al quesito occorre sperimentare il processo produttivo nella sua concretezza. In ogni fase produttiva il lavoratore riceve una retribuzione corrispondente alla situazione economica (tecniche, mezzi di produzione, infrastrutture, conoscenze, ecc.) nella quale opera, ma egli lavorando non si limita a riprodurre le condizioni della produzione così come le ha ereditate dal passato. Al contrario le riproduce in forma innovativa, cosicché i mezzi di produzione nuovi, le infrastrutture nuove, le conoscenze nuove rendono il lavoro corrente enormemente più produttivo di quello che era e quello futuro enormemente più produttivo di quello corrente. Le organizzazioni dei lavoratori, allora egemoni, hanno riconosciuto questo dato di fatto, e si sono battute affinché in ogni epoca storica, nella quale i lavoratori attivi godevano di una produttività sensibilmente maggiore creata dal lavoro di chi li aveva preceduti, rendessero partecipi i pensionati di quella ricchezza aggiuntiva al di là dei contributi versati durante la vita lavorativa, che non poteva includere l’arricchimento della società al quale aveva contribuito. Ciò non solo era giusto, ma addirittura economicamente doveroso, in quanto l’aumento della produttività sarebbe altrimenti sfociato in un problema di sovrapproduzione strutturale. Infatti l’aumento della capacità produttiva che non si accompagna ad un aumento della domanda aggregata sfocia inevitabilmente in un blocco della produzione corrente, e nella disoccupazione, per mancanza di una spesa corrispondente che la comperi.
L’applicazione del sistema contributivo, oggi imposto ai nuovi lavoratori, ma che si vuole estendere anche ai pensionati, contraddice questa logica, appunto perché tratta la questione previdenziale non già come una questione che investe il funzionamento del sistema economico nel suo complesso, ma come un fatto meramente privato.
La validità del metodo contributivo era limitata alla realtà economica prekeynesiana, quando le imprese svolgevano positivamente il loro ruolo storico, appropriandosi del prodotto eccedente e reinvestendolo nell’espansione del sistema economico per accumulare il loro capitale. Ma già Keynes riconobbe che sin dalla crisi degli anni trenta le cose erano radicalmente cambiate. Le imprese non riuscivano più a svolgere quella funzione assunta col prevalere della borghesia, cosicché bisognava garantire una sbocco alternativo a quel prodotto aggiuntivo reso possibile dall’innovazione continua, pena l’instaurarsi di una tendenza strutturale al ristagno.
L’allungamento del periodo di formazione individuale prima del lavoro, passato dai 13-15 anni degli anni cinquanta ai 20-25 anni di oggi, che ha permesso ai giovani di godere anticipatamente dei frutti degli aumenti di produttività, ritardando il loro ingresso al lavoro, è uno dei momenti di quella politica. Così come con il sistema delle pensioni a ripartizione, con vitalizi superiori a quelli calcolati col metodo delle rendite attuariali, è stato solo il modo di rendere possibile il godimento posticipato di quel prodotto aggiunto derivante dal continuo aumento della produttività garantito dal lavoro pregresso.
Quando trent’anni fa ci costrinsero ad accantonare quella politica era stato promesso un mondo aperto e capace di assicurare uno straordinario sviluppo, con reddito e lavoro per tutti. Nei fatti, in tutta Europa, stiamo invece assistendo ad un progressivo degrado, al quale occorre porre rimedio prima che le forze produttive residue vengano definitivamente dissipate.
*Docente di politiche economiche dello sviluppo
Direttore Centro Studi e Iniziative per
la Redistribuzione del lavoro
@ Riproduzione riservata www.redistribuireillavoro.it - Centro Studi e iniziative per la riduzione del tempo individuale di lavoro e redistribuzione del lavoro sociale complessivo