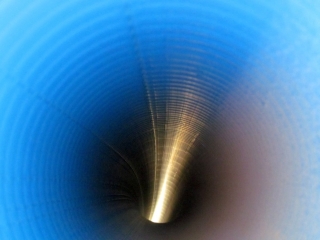L’imbroglio del “RITORNO ALLA CRESCITA”
pubblicato sul sito Dizionariodellacrisi.wikispaces.com
Va bene che, come ha detto Marx, “le idee dominanti in ogni epoca sono le idee della classe dominante”, ma c’è un limite a tutto! Non basta, infatti, che la classe dominante sostenga che gli asini volino, per farli volare. Anche se qualcosa di simile sta, purtroppo, accadendo oggi sul terreno della politica economica. Da Sarkozy a Berlusconi, dalla Merkel e Zapatero, da Veltroni a Bersani, da Di Pietro a Tremonti, da Epifani alla Mercegaglia, e giù elencando, da quando è scoppiata la crisi non si sente ripetere altro: per uscire dalla crisi occorre riavviare la crescita”. Nessuno che sull’argomento coltivi un dubbio o convenga sull’esistenza di un problema.
Il valore ambivalente della crescita
Chi può negare che ci siano fasi della vita individuale e collettiva nelle quali la crescita rappresenta un fenomeno decisamente positivo. Come l’aumento di statura e di peso di un bambino è cosa positiva, così l’aumento della disponibilità di beni materiali, di mezzi di produzione e di risorse in una società economicamente arretrata è cosa buona. Ma nel caso dell’organismo individuale si raggiunge ben presto un punto – della maturità biologica – al di là del quale ogni ulteriore crescita si trasforma in qualcosa di negativo. Se un ragazzo che ai vent’anni pesava 70-80 chili continua a crescere, raggiungendo i 120-130 chili, ci troviamo di fronte ad un’evoluzione patologica: l’obesità.
Gli economisti conservatori sostengono che, per la società nel suo insieme, questa “legge” non vale. La loro convinzione è che “la domanda non conosca limiti”, cosicché, non solo “il bisogno di accumulare sussisterà invariato nel tempo”, ma la crescita costituirà sempre un fenomeno fisiologico. Non entrerò nel merito di come l’esperienza quotidiana confuti praticamente questa convinzione: dal problema dello smaltimento dei rifiuti, alla congestione del traffico, all’intasamento mediatico, alla distruzione dell’ambiente per eccessiva urbanizzazione. Mi preme piuttosto sottolineare come questa convinzione faccia a pugni con tutta la storia economica del Novecento, che depone contro l’unanime appello odierno alla crescita, come unica condizione per affrontare la crisi. E soprattutto confuta radicalmente le convinzioni prevalenti sul modo in cui perseguirla.
Il ruolo della spesa pubblica
La tesi più diffusa, rilanciata con forza in questi giorni drammatici, è che per tornare a crescere si debba tagliare la spesa pubblica. Era la tesi prevalente all’inizio degli anni Trenta, e là dove fu accolta determinò ulteriori crolli produttivi. Si potrebbe dire, beh che c’è di male nel riprendere una tesi del passato, visto che è così largamente condivisa? C’è che si tratta di una tesi sbagliata, perché incorrere in un errore che era già stato ampiamente chiarito da Keynes nel corso degli anni Trenta. In una trasmissione radiofonica del 1933, ad esempio, quello studioso sostenne apertamente che “ogni sterlina risparmiata è un’occupazione cancellata”, e che la politica dei tagli alla spesa pubblica non è altro che “una campagna nazionale per l’aggravamento della disoccupazione”.
Che cosa aveva compreso Keynes per giungere ad una conclusione così perentoria? Aveva capito che il lavoro viene messo in moto se e soltanto se interviene una spesa, una qualsiasi spesa. I suoi avversari avanzavano una tesi opposta, e cioè che c’è uno ed un solo tipo di spesa che garantisce la creazione di lavoro, quella in investimenti capitalistici, perché è l’unica a permettere una conservazione del valore del prodotto ed una sua crescita. E se questa spesa non è possibile, ad esempio perché le imprese stanno subendo perdite, bisogna risparmiare, perché qualsiasi spesa in consumi sarebbe solo dissipatoria.
Keynes criticò questa convinzione sostenendo che essa descriveva bene il meccanismo della prima fase di sviluppo dei rapporti capitalistici, quando il capitale era scarso, ma che da inizio Novecento il quadro generale era radicalmente cambiato e quella teoria si trasformava in un trappola. Il punto cruciale delle sue argomentazioni sta nell’individuazione del cosiddetto “paradosso del risparmio” che è forse opportuno richiamare con le sue chiare parole. Nella nostra società, “noi produciamo per vendere. In altri termini, produciamo in risposta ad una spesa. E’ impossibile pensare di poter stimolare la produzione e l’occupazione – come suggeriscono i cultori di una finanza sana e gli economisti ortodossi – rinunciando a spendere … Mi rendo conto che gli ascoltatori possono nutrire dei dubbi, visto che lo spendere viene in genere inteso come un comportamento stravagante. Un individuo stravagante si rende ben presto povero. Come può allora un paese diventare ricco facendo proprio quello che renderebbe povero un individuo? Nel riflettere su questo punto la gente rimane così interdetta. Eppure un comportamento che può rendere un singolo individuo povero può rendere una nazione ricca. Infatti, quando un individuo spende non influenza soltanto se stesso, ma gli altri. La spesa è una transazione bilaterale. Se spendo il mio reddito nell’acquisto di qualcosa che tu puoi produrre per me non aumento il mio reddito, ma aumento il tuo. Se tu rispondi comperando qualcosa che io posso fare per te, allora anche il mio reddito aumenta. Pertanto, quando ci riferiamo al paese nel suo insieme dobbiamo tener conto dei comportamenti complessivi. Il resto della società è arricchita dalla spesa di un individuo – poiché la sua spesa non è altro che un aggiunta al reddito di ciascuno. … Rinunciare a spendere in una fase di depressione, non solo fallisce, dal punto di vista della società, nell’aggiungere ricchezza, ma addirittura la dissipa: significa spreco di forza-lavoro disponibile, spreco di capacità roduttiva esistente, oltre alla miseria umana di cui diventa responsabile”. Ma il rinunciare a spendere in momenti di difficoltà economica è proprio quello che fanno sia la classe egemone, nel cui perseguimento dell’accumulazione è collocato il destino della riproduzione della società, sia le classi subordinate, per premunirsi dai guai futuri. Cosicché la possibilità di produrre e di soddisfare bisogni si scontra con una limitatezza della spesa.
Qui è dove storicamente interviene il ruolo dello stato. “Se per una qualsiasi ragione”, continua Keynes, “gli individui [e le imprese] non sono disposti, ognuno nella propria misura e capacità privata a spendere abbastanza per impiegare le risorse di cui la società è dotata, allora spetta al governo, il rappresentante collettivo di tutti gli individui, ripianare il buco”. Si noti il rovesciamento rispetto al senso comune prevalente: il “buco” non sta nella spesa eccessiva, bensì nella mancata spesa, rispetto all’ammontare necessario per impiegare pienamente le risorse disponibili.
Il paradosso della necessità del deficit pubblico
Fino a metà anni Settanta questa strategia prevalse, dando vita ai “miracoli economici” di molti paesi. Ma questi miracoli non erano altro che la realizzazione dell’ulteriore crescita possibile. Per questo, quando raggiunse il suo obiettivo, col recedere della miseria di massa, emerse un problema nuovo: anche la spesa pubblica non riusciva a far crescere il sistema agli stessi tassi del periodo precedente.
Fintanto che sussisteva ancora la possibilità di una crescita fisiologica, e cioè c’era una moltitudine di bisogni primari facilmente soddisfacibili, la spesa pubblica generava, come effetto secondario un aumento del reddito multiplo rispetto alla spesa originaria. Cosicché “l’aumento dei redditi delle persone forniva i mezzi per la spesa aggiuntiva del governo”, senza che questi si trovasse “senza soldi”. Grazie a questo effetto moltiplicativo del reddito, non comparivano deficit nel bilancio pubblico.
Ma quando anche la spesa pubblica dovette fare indirettamente i conti con la saturazione dei mercati, cioè con il venir meno di un’ulteriore crescita spontanea indotta dall’esborso pubblico, o la società accettava il deficit, impegnandosi a soddisfare i bisogni necessari ancora insoddisfatti, o il sistema sarebbe ricaduto nella stessa trappola nella quale era precipitato prima dell’affermarsi dello Stato sociale keynesiano.
@ Riproduzione riservata www.redistribuireillavoro.it - Centro Studi e iniziative per la riduzione del tempo individuale di lavoro e redistribuzione del lavoro sociale complessivo